L’autunno negli Appennini non è solo foreste dorate, ma anche il profumo delle caldarroste che invade le strade di paesi e borghi. Qui i castagni per secoli non sono stati soltanto una leccornia, ma una base dell’alimentazione e un pilastro dell’agricoltura locale. Oggi vivono una nuova rinascita: dai mercati tradizionali fino ai ristoranti di alta cucina.
Il pane storico d’Italia
Nel Medioevo il castagno era considerato il “pane dei poveri”. Con la sua farina si preparavano focacce, polente e zuppe. Questo era vitale soprattutto nelle zone montane, dove la coltivazione dei cereali era limitata. I castagni salvarono intere famiglie dalla fame e ancora oggi in Toscana, Liguria ed Emilia si trovano piatti tipici a base di farina di castagne.
«Per i miei nonni il castagno era ciò che per gli altri era il grano», racconta l’agricoltore Giovanni Rizzi della Garfagnana.
Le piantagioni di oggi
Oggi l’Italia è tra i maggiori produttori di castagne in Europa. Le principali aree di raccolta sono Toscana, Piemonte e Campania. Negli Appennini gli agricoltori mantengono antichi castagneti e ne impiantano di nuovi, spesso con certificazioni biologiche.
Il raccolto del 2025 è stimato intorno alle 45–50 mila tonnellate, destinate in gran parte al mercato interno.
Economia e gastronomia
Le castagne in Italia si vendono sia fresche che trasformate. La farina di castagne viene utilizzata per pane, pasta e persino dolci. Nei ristoranti di alta gamma si servono puree di castagne con selvaggina, vellutate e dolci come il “Mont Blanc”.
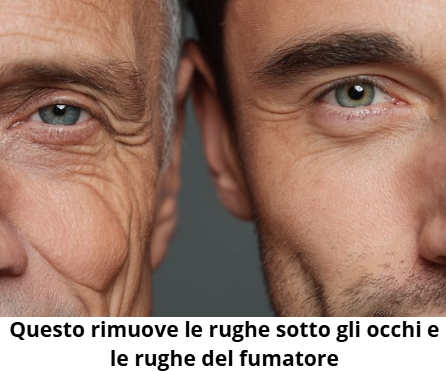
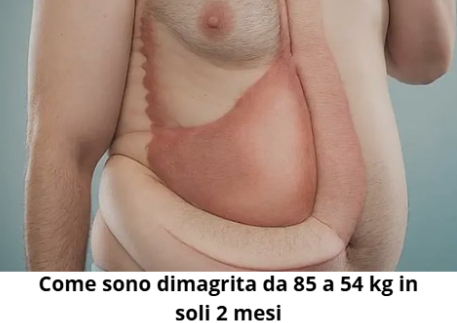
Nei mercati autunnali il prezzo medio è di 4–6 euro al kg per le castagne fresche, mentre la farina biologica di castagne può raggiungere i 12–15 euro al kg.
Turismo e feste popolari
L’autunno negli Appennini è anche la stagione delle sagre del castagno. Nei borghi toscani e liguri si organizzano feste dove le castagne vengono arrostite in padelle giganti, accompagnate da dolci tradizionali e vino novello. Questi eventi attirano migliaia di turisti e sostengono l’economia locale.
«La sagra del castagno è la festa di tutto il paese. La gente viene per ritrovare i sapori dell’infanzia», racconta una residente di Castelnuovo di Garfagnana.
Le sfide degli agricoltori
La principale minaccia per i castagneti sono parassiti e malattie. Negli ultimi anni il cinipide galligeno del castagno ha provocato gravi danni, costringendo molti produttori a rinnovare le piante. Gli agricoltori investono quindi in sistemi di difesa biologica e in varietà più resistenti.
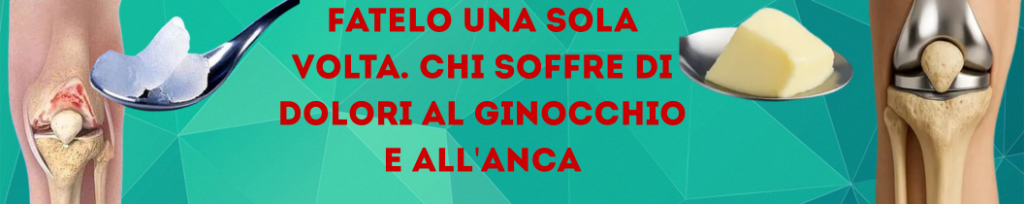
Conclusione
I castagni degli Appennini non sono solo un prodotto, ma un pezzo di storia, cultura e agricoltura italiana. Dal semplice “pane dei poveri” si sono trasformati in una prelibatezza che unisce passato e presente. In autunno il loro profumo torna a riempire le strade dei borghi, ricordando che le tradizioni possono convivere con la modernità.






















